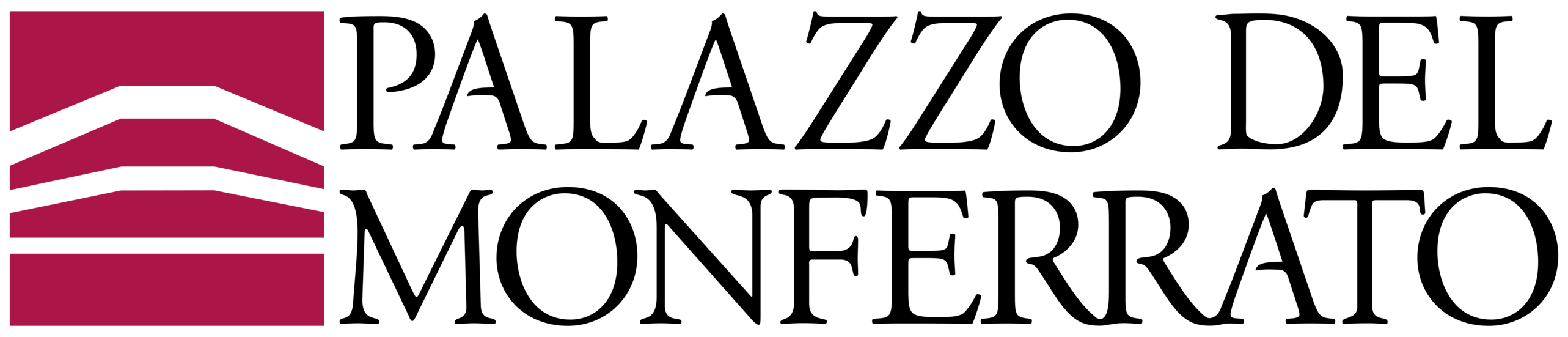CENNI STORICI
La Camera di Commercio delibera l’acquisto di un’area edificabile di circa 600 metri quadri in pieno centro cittadino, all’angolo tra le vie Piacenza e Cavallotti (attuale via San Lorenzo) per costruirvi una sede di proprietà, esigenza assai sentita in relazione alla crescita delle competenze e del personale.
Il commissario governativo Cristoforo Ponzano indice un concorso nazionale per la scelta del progetto al quale prendono parte circa trenta concorrenti, tra i quali diversi professionisti locali. Il concorso, però, non ha buon esito, perché nessuno dei progetti presentati è ritenuto accettabile: alcuni di questi elaborati vengono pubblicati su riviste specializzate e di essi (come di quello realizzato dallo studio Titta) è rimasta qualche traccia documentaria.
In seguito a un secondo concorso con analogo esito, il commissario Ponzano assume la responsabilità di assegnare direttamente al celebre architetto torinese Giovanni Chevalley (1868-1954), collaboratore di Carlo Ceppi, l’incarico di progettare l’edificio. Il progetto viene effettivamente approvato il 15 novembre, congiuntamente al piano finanziario per la sua realizzazione che prevede la copertura di una spesa pari a lire 1.650.000 (di cui la Camera già aveva accantonato 1.200.000).
In coincidenza con la creazione dei Consigli provinciali dell’economia, il prefetto Selvi, nella sua veste di presidente del Consiglio dell’economia, pensa di rinunciare al progetto originario, portando la sede dell’ente all’interno del palazzo Reale (palazzo Ghilini) che già ospitava gli uffici della prefettura e della provincia, affidando un incarico all’architetto milanese Portalupi.
Con il prefetto Milani si torna all’impostazione originaria e si procede all’acquisto da un vicino di una piccola porzione di terreno edificabile che avrebbe reso più regolare il perimetro del nuovo edificio e si chiede all’architetto Chevalley di apportare ulteriori modifiche al proprio progetto in vista di questa nuova acquisizione.
Il 28 ottobre, con il prefetto Rebua, ha luogo la cerimonia (simbolica) della posa della prima pietra dell’edificio.
Il 25 gennaio viene pubblicato l’avviso d’asta per l’aggiudicazione dei lavori, assegnati successivamente alla società anonima Impresa di Costruzioni Bastita & C. di Tortona (assistente dei lavori il geom. Luigi Ostanello).
il 5 novembre si procede alla consegna dei lavori e all’inaugurazione della sede del Consiglio provinciale dell’economia corporativa. La circostanza è segnata dalla presenza del sottosegretario alle corporazioni, on. Bruno Biagi, accolto da Rebua e da Vaccari da una solenne seduta del Consiglio appena costituito e dalla realizzazione di una medaglia commemorativa, disegnata dallo stesso progettista. Il verbale della seduta, redatto su pergamena, viene depositato tra gli atti solenni ad tradendam rei memoriam.
Il 13 giugno l’ing. Arturo Danusso di Milano sottoscrive la relazione di collaudo dei lavori consentendo così l'attuazione del trasloco definitivo.

Costi e realizzazione
Le spese di costruzione, autorizzate in un primo tempo nella cifra di due milioni di lire, ma poi contenute nella misura di lire 1.568.422, furono finanziate con la cassa per l’importo di lire 1.091.935 e con la vendita di titoli del debito pubblico per la cifra di lire 500.000 (per ragioni di cautela si richiese anche un’anticipazione di lire 200.000 alla locale Cassa di Risparmio).
Il nuovo Palazzo delle Corporazioni era articolato su un piano terreno, ove trovava posto un ampio salone delle adunanze (capace di oltre 100 posti a sedere), affrescato dal pittore locale Giovanni Patrone dopo che ebbe rinunciato all’incarico il torinese Carlo Gaudina (1878-1939).
Il progetto prevedeva poi un mezzanino, un piano nobile che ospitava gli uffici di presidenza e di segreteria, la sala del consiglio e la biblioteca, un secondo piano adibito a uffici e un ampio sottotetto attrezzato ad archivio.
L’edificio, con una superficie utile complessiva pari a circa 1.900 metri quadri fu sede degli uffici camerali per circa settant’anni, cioè fino al 2001. Dopo il trasferimento nell’attuale sede di via Vochieri 58, l’edificio – rimasto comunque a far parte del patrimonio camerale – ha assunto la denominazione di Palazzo Asperia e poi quella di Palazzo del Monferrato ed è utilizzato come sede espositiva attrezzata e sede di alcuni uffici.